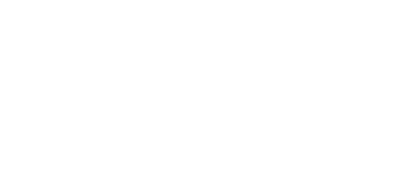Olimpia Fontana / 25 settembre 2025
Commento n. 010/2025 NS
Nel discorso alla Conferenza di alto livello organizzata dalla Commissione europea sullo stato di avanzamento del celebre Rapporto che porta il suo nome, Mario Draghi è stato chiaro: “Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno.” Eppure un anno fa il suo messaggio fu esplicito: l’Ue deve essere in grado di crescere, innovare e raggiungere un’autonomia strategica nelle tecnologie del futuro. Per farlo serve un cambio radicale: non bastano aggiustamenti, ma riforme profonde, coordinamento politico, investimenti massicci e una governance più efficace. Una politica industriale europea è lo strumento riscoperto dall’Ue per rispondere alla feroce concorrenza, e inevitabili tensioni, da parte di Stati Uniti e Cina. Ma nell’assetto istituzionale attuale di politica economica europea tale arma si basa su un pilastro debole, quello del coordinamento tra iniziative nazionali volontarie.
Come sottolinea Draghi, l’Ue è rimasta per troppo tempo intrappolata in una doppia morsa: da un lato fare affidamento su sforzi nazionali non coordinati, dall’altro riporre una fiducia totale nell’idea che le sole forze di mercato possano creare nuovi settori. Ma se il primo approccio non è in grado di produrre risultati su larga scala nei settori che contano, il secondo risulta altrettanto illusorio, soprattutto quando altri attori a livello globale intervengono massicciamente nel mercato e ne alterano le condizioni di concorrenza. Il campanello d’allarme di Draghi riguarda oltre ai settori della difesa e dell’industria pesante anche quello delle tecnologie d’avanguardia che plasmeranno il futuro.
In questo campo l’Ue si sta lentamente svegliando dal torpore che per decenni ha impedito una reale politica industriale, grazie a una particolare clausola del Trattato (art. 107(3)(b) del TFEU), quella sugli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI). Si tratta di ampie iniziative transnazionali, riconosciute dalla Commissione europea, con cui agli Stati membri viene concesso di elargire aiuti di Stato in settori chiave fortemente innovativi (ad es. batterie, idrogeno, microelettronica, cloud) in deroga alle regole abituali. Dal 2018 sono stati attivati 11 IPCEI, con una partecipazione totale di 23 paesi membri, 257 imprese, per un totale di 37 miliardi di euro di aiuti pubblici. Data l’importanza, l’urgenza e la complessità di sostenere gli IPCEI esistenti e avviarne di nuovi, dal 2021 la Commissione ha intrapreso diverse azioni non solo per potenziarne l’uso, ma soprattutto per renderli più trasparenti, inclusivi e veloci.
Seppur un importante passo in avanti nel superamento della disciplina sugli Aiuti di stato, gli IPCEI sono essenzialmente uno strumento di raccordo e coordinamento per una moltitudine di piccole, medie e grandi imprese selezionate, a cui è esplicitamente riconosciuto il via libera del finanziamento pubblico. Mettere insieme attori con elevata propensione all’innovazione, ma con diverse capacità finanziarie e amministrative, provenienti da paesi membri i cui governi hanno margini fiscali diversi, è la sfida di questo enorme sforzo di coordinamento.
Essendo materia controversa per il conflitto tra politica industriale e politica di concorrenza (intervento pubblico contro rischio di frammentazione), innanzitutto la Commissione ha chiarito con la Comunicazione del 2021 i criteri di ammissibilità e compatibilità per approvare gli aiuti di Stato in funzione della partecipazione a un IPCEI, il quale deve: dare un contributo a un obiettivo strategico dell’Ue, dimostrare di ovviare a gravi fallimenti di mercato o sistemici (o a sfide sociali) che, in assenza di aiuti, ne impedirebbero la realizzazione, coinvolgere almeno quattro Stati membri. Un requisito importante è quello di apportare vantaggi non solo agli Stati membri finanziatori o alle imprese coinvolte, ma a una porzione più vasta dell'Unione.
Il concetto di bene pubblico è quindi alla base della decisione di avviare un IPCEI: pur non essendo beni pubblici europei “puri”, si basano su una logica di bene pubblico europeo, perché mirano a creare valore e vantaggi che vanno ben oltre l’impresa o lo Stato che partecipa al progetto. Per i partecipanti vi è l’obbligo di condividere e trasferire le conoscenze sviluppate grazie agli aiuti di Stato dall’IPCEI lungo l’intera catena del valore, sia nei mercati a monte che in quelli a valle.
Nel 2023 è stato creato il Joint European Forum for IPCEI, uno speciale gruppo di discussione a cui partecipano i servizi della Commissione e i rappresentanti degli Stati membri (per l’Italia il Ministero delle Imprese e del made in Italy). Attraverso il JEF sono state definite le best practices relative alle varie fasi del processo in cui si articola un IPCEI, sulla base dell’esperienza finora maturata. L’obiettivo è chiaramente quello di razionalizzare e snellire un processo altamente complesso e provare a rispondere alla crescente frustrazione provata da cittadini e imprese europee circa la lentezza, decisionale e amministrativa, con cui si muove l’Ue. Inoltre, nel forum vengono identificati i futuri IPCEI di natura strategica, su indicazione degli Stati membri. Va segnalato che è in corso di discussione l’avvio di progetti nei settori delle biotecnologie, dei veicoli puliti, connessi e autonomi e delle materie prime critiche.
Rispetto alla governance, la procedura per attuare un IPCEI è articolata. La fase iniziale consiste nell’identificazione di un nuovo IPCEI e nella sua successiva comunicazione da parte dei paesi aderenti. Segue la fase di progettazione, in cui ciascuno stato membro avvia la selezione degli attori interessati sul territorio nazionale. Imprese e centri di ricerca sono invitati a partecipare a eventi di match-making per promuovere collaborazioni e identificare sinergie tra i potenziali partecipanti degli altri paesi aderenti. In questa fase le imprese selezionate e le autorità nazionali preparano documenti come il project portfolio e le proiezioni di funding gap. Lo step successivo consiste nella pre-notifica da parte della Commissione della documentazione ricevuta a cui segue, dopo vari aggiustamenti, l’effettiva notifica dell’intero IPCEI. Qui viene dato il semaforo verde dall’Ue agli Aiuti di stato richiesti. Saranno poi gli Stati membri a concedere ed erogare l'aiuto approvato alle proprie imprese domestiche, fermo restando che l'erogazione dipende dalla disponibilità di fondi nel bilancio nazionale.
Dal quadro emerge quindi che nella fase di notifica e autorizzazione la Commissione gioca un ruolo centrale, ma di fatto l’individuazione, la selezione e la realizzazione dei progetti sono in mano alle autorità nazionali e alle imprese domestiche. Sebbene l’Ue abbia voluto razionalizzare e codificare l’intero processo istituendo linee guida, template, servizi di supporto al fine di renderlo più snello e veloce, la natura della politica industriale europea resta quella di un coordinamento di varie iniziative nazionali, basate sulla volontà di cooperare, sulle capacità amministrative e i margini fiscali degli stati membri nonché sulla potenzialità di crescita delle imprese, le quali a loro volta risentono di un mercato dei capitali europeo frammentato e di una carenza di domanda interna stabile e prevedibile.
Infine, resta il nodo del finanziamento dei progetti IPCEI, che in alcuni casi hanno beneficiato anche di una parte di co-finanziamento europeo durante il NGEU. Nelle prossime settimane si terranno nuove riunioni del JEF, la cabina di comando. In quell’occasione verrà effettuata una mappatura dei fondi e dei programmi esistenti a livello europeo che possono essere impiegati per co-finanziare i progetti IPCEI. Tuttavia, senza la disponibilità di risorse aggiuntive dedicate agli IPCEI difficilmente si raggiungeranno gli obiettivi prefissati. Un esempio è il caso dei finanziamenti associati al Chips Act. La Corte dei conti europea ha considerato insufficiente il livello di investimenti totali associato alla strategia sui semiconduttori, sebbene venga riconosciuto il ruolo positivo degli IPCEI nel sostenerne l'industria. Data la natura di bene pubblico europeo degli IPCEI, un maggiore finanziamento e una più ampia gestione dell’intero processo a livello centrale europeo potrebbero contribuire a ridurne la lentezza e le inefficienze.
*Senior Visiting Fellow FCSF

 It
It  En
En