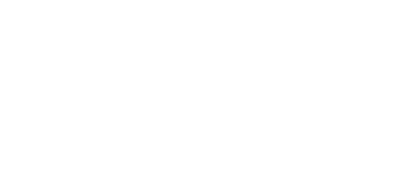Nicoletta Pirozzi / 30 luglio 2025
Commento n. 006/2025 NS
Il contesto di sicurezza europeo è cambiato radicalmente il 24 febbraio 2022, con l'aggressione russa contro l'Ucraina e il ritorno della guerra sul continente europeo.
Al momento dell'attacco, l'UE stava per completare un processo biennale volto a realizzare una convergenza strategica tra gli Stati membri e a definire obiettivi concreti per rafforzare la politica di difesa europea. Il risultato, la Bussola Strategica pubblicata il 22 marzo 2022, è nato già obsoleto. Affrontare la nuova realtà richiede una maturazione della visione e degli strumenti di difesa europea utilizzati finora. Ci sono tre sfide principali che definiranno la difesa europea nei prossimi anni e che dovrebbero diventare le priorità per l’attuale leadership europea.
La prima sfida riguarda la necessità di decidere in modo rapido ed efficace.
La guerra in Ucraina ha mostrato ancora una volta i limiti del funzionamento della politica estera dell'Unione. A partire dalle difficoltà incontrate nell'approvazione dei vari pacchetti di sanzioni a Mosca o dell’apertura dei pacchetti negoziali per l’adesione di Kyiv, sono emerse tutte le disfunzioni di un'area che mantiene una forte impronta intergovernativa, dominata dalla logica del consenso e quindi dagli esecutivi nazionali e dalle loro priorità. In passato, queste disfunzioni avevano causato la paralisi dell'Unione di fronte a crisi e conflitti come in Libia, nel Sahel e in Medio Oriente. Oggi appare chiaro che se l'Europa vuole davvero completare la sua trasformazione in una potenza globale, deve procedere all’adozione di procedure decisionali adeguate a sostegno di tale ambizione.
Procedere in modo compatto con 27 Stati membri e forse anche più (si ricordi la prospettiva di un ulteriore allargamento dell'UE a Ucraina, Moldova e Georgia, oltre ai Paesi candidati dei Balcani Occidentali) è diventata la sfida più grande sulla strada verso una maggiore integrazione delle politiche di difesa. Mentre l'Unione lavora verso una convergenza strategica tra i suoi membri, non è più possibile procrastinare una semplificazione del suo processo decisionale.
La seconda sfida è quella di favorire la cooperazione industriale.
Di fronte alle sfide attuali, gli Stati membri e la Commissione europea hanno adottato diverse iniziative europee in materia di difesa, come la creazione del Fondo europeo per la pace (European Peace Facility) per finanziare i costi comuni delle operazioni militari dell'UE e le misure di assistenza a beneficio dei paesi partner dell'UE, la revisione del Piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan) per individuare le lacune critiche in termini di capacità, l'adozione della Strategia per l'industria della difesa europea (EDIS) e la proposta di un Programma per l'industria della difesa europea (EDIP) per preparare l'industria della difesa dell'UE per il futuro, nonché il meccanismo SAFE (Security Action for Europe) per incentivare gli approvvigionamenti comuni.
Tuttavia, il mercato europeo è caratterizzato da una marcata frammentazione. L’insufficiente coordinamento tra gli Stati membri in materia di ricerca, sviluppo e acquisizioni in comune ha limitato l’efficacia degli investimenti e ha reso l’UE meno competitiva a livello globale: bisogna intervenire con maggiori risorse per favorire progetti di cooperazione industriale, appalti congiunti e armonizzazione normativa.
La terza sfida è quella di razionalizzare l'architettura di difesa dell'UE.
Le recenti crisi hanno portato a un diffuso riconoscimento della necessità che l'UE acquisisca ulteriori competenze nel campo della difesa. Nella Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini europei hanno chiesto più Europa nel settore della difesa e Ursula von der Leyen ha incluso il completamento di un'Unione Europea della Difesa tra le priorità del suo mandato, a partire dalla redazione di un Libro Bianco sul Futuro della Difesa Europea nei suoi primi 100 giorni. Eppure, la politica di difesa rimane fondamentalmente intergovernativa.
La decisione di istituire un Commissario europeo per la Difesa potrebbe essere considerata un passo verso una sovra-nazionalizzazione della politica di difesa, ma comporta un doppio rischio. Nella prima parte della nuova legislatura, si è creata la falsa equazione tra difesa europea e industria europea della difesa. La Commissione Europea ha guidato progressi significativi in questo campo, come l’iniziativa Readiness 2030 – Rearm Europe, ma ci sfugge ancora l'aspetto della politica di difesa, appannaggio esclusivo degli Stati membri. Questo genera anche pericolosi disequilibri istituzionali, caratterizzati da bruschi balzi in avanti da parte della Commissione Europea, che in ultima analisi alienano gli Stati membri, i principali azionisti in questo settore.
Serve dunque un bilanciamento che veda l’iniziativa degli Stati membri, ragionevolmente un gruppo ristretto di Paesi volenterosi e dotati delle necessarie capacità che dia impulso al processo di integrazione verso una vera politica di difesa.
Le tre sfide – il decision-making, la cooperazione industriale e la governance della difesa – possono trovare soluzioni concrete. Ma il successo dipenderà da una volontà politica forte: superare l’unanimità, rafforzare istituzioni sovranazionali e accettare un grado di integrazione che molti Stati membri finora hanno evitato. Solo allora l’Europa potrà realmente spezzare i tabù storici sulla difesa comune e trasformarsi in una presenza credibile e autonoma nel contesto globale.
*Responsabile del programma “UE, politica e istituzioni” e delle relazioni istituzionali, IAI. Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione CSF

 It
It  En
En