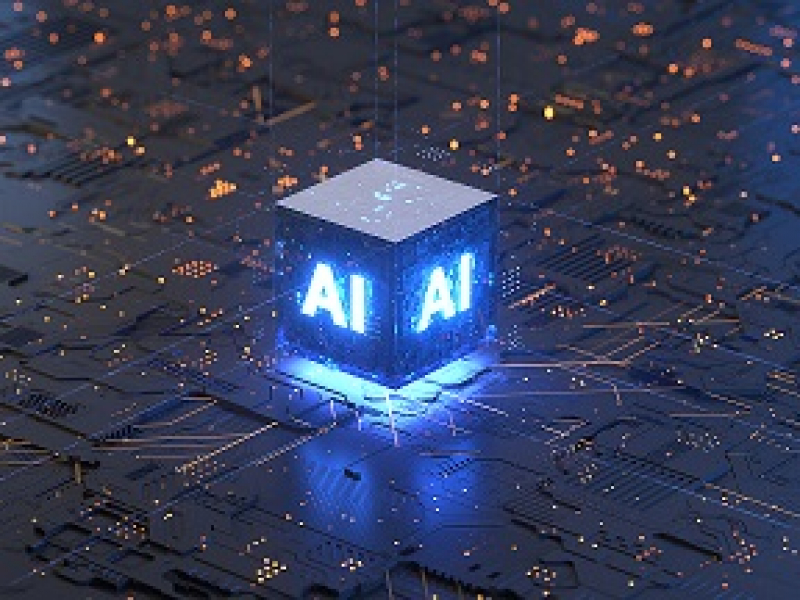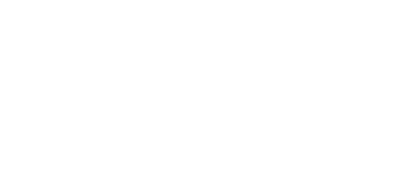Veronica Sacco / 15 settembre 2025
Commento n. 009/2025 NS
La decisione del primo ministro Edi Rama di nominare “Diella”, un sistema di intelligenza artificiale già attivo su e-Albania come assistente digitale, a “ministra virtuale” con delega agli appalti pubblici è, allo stesso tempo, gesto politico, esperimento amministrativo e test di credibilità internazionale. Sul piano simbolico l’operazione è potente: l’avatar in abiti tradizionali incarna la promessa di una modernizzazione radicata nell’identità nazionale; sul piano giuridico-istituzionale è invece un terreno ancora da dissodare, perché la natura “virtuale” della ministra solleva interrogativi sulla titolarità degli atti, la responsabilità in caso di errore e l’effettiva compatibilità con il quadro costituzionale e con l’acquis comunitario in materia di appalti e tutele giurisdizionali. L’annuncio, formalizzato tra l’11 e il 12 settembre 2025, ha catturato l’attenzione dei media globali e ha subito diviso osservatori e opposizioni sull’opportunità e sulla legittimità della scelta.
Per comprendere l’azzardo di Tirana occorre guardare al contesto. L’Albania ha fatto negli ultimi anni passi avanti sul versante della digitalizzazione amministrativa e ha interesse strategico a segnalare all’Unione europea di saper affrontare le aree grigie dello Stato di diritto, a partire proprio dal procurement, tradizionalmente esposto a conflitti di interessi, condizionamenti politici e rendite. La nomina di Diella cade inoltre in una fase di forte pressione giudiziaria anticorruzione: l’attività della procura speciale SPAK ha coinvolto figure apicali, fino all’arresto del sindaco di Tirana Erion Veliaj e all’avvio del relativo procedimento, creando un clima interno in cui la promessa di una “tecnicizzazione” delle aggiudicazioni può apparire come valvola di sfogo e, insieme, come narrativa salvifica. Ma proprio per questo il rischio di strumentalizzazione politica è evidente: senza garanzie sostanziali, la retorica dell’algoritmo neutrale può diventare un velo sull’opacità, non il suo antidoto.
C’è poi un nodo di governance che non può essere eluso. Il governo ha indicato collaborazioni con grandi fornitori tecnologici, e fonti di stampa hanno citato in modo esplicito Microsoft come partner: è un’informazione rilevante perché, se l’infrastruttura che “sostituisce” la discrezionalità ministeriale è anche un’infrastruttura proprietaria, allora il problema non è solo tecnico ma politico: chi controlla il codice, i dati e le metriche di performance? Qual è il regime di audit, cosa è sindacabile in giudizio e come si previene il lock-in contrattuale che limiterebbe la sovranità digitale dello Stato? La trasparenza promessa non può fermarsi alla pubblicazione dei risultati; deve includere il processo: set di dati, criteri di scoring, pesi, log delle decisioni, tempi e contenuti degli aggiornamenti di modello. In assenza di questi elementi, la “ministra” rischia di diventare una scatola nera con la quale scaricare sull’algoritmo responsabilità eminentemente pubbliche.
Il diritto europeo offre qui un perimetro chiaro. L’AI Act, entrato in vigore nel 2024, adotta un approccio basato sul rischio e, per i sistemi ad alto rischio impiegati dalla pubblica amministrazione, richiede gestione del rischio, qualità dei dati, registrazione degli eventi, tracciabilità, documentazione tecnica, trasparenza e, soprattutto, supervisione umana efficace. In altre parole, l’IA nel settore pubblico deve essere “assistente” e non “sostituto”, e le decisioni che incidono su diritti, concorrenza e denaro pubblico devono rimanere motivabili e impugnabili davanti a un giudice in carne e ossa. La “diellacrazia” è compatibile con Bruxelles solo se si traduce in un sistema con valutazioni d’impatto, log immutabili, spiegazioni ex post e figure responsabili chiaramente identificate.
Per valutare l’efficacia di un intervento simile conviene poi guardare alle pratiche che in Europa orientale hanno funzionato davvero. L’Ucraina ha costruito negli anni un ecosistema di procurement digitale fondato su apertura dei dati, concorrenza e controllo civico: ProZorro e DoZorro non hanno “nominato” un algoritmo ministro, ma hanno messo in piazza, in tempo reale, tutte le fasi delle gare, ottenendo risparmi misurabili e un innalzamento dell’accountability in un contesto altrimenti difficilissimo. Questo non significa che l’IA non serva; significa che rende al massimo quando integra — non sostituisce — regole e vigilanza, ad esempio usando tecniche di anomaly detection per segnalare clausole escludenti, schemi di collusione o pattern di ribassi sospetti a revisori umani qualificati.
Il profilo geopolitico è trasparente. Tirana scommette di presentarsi come campione della governance digitale nei Balcani occidentali, trasformando la tecnologia in capitale negoziale nel percorso di allargamento. Se Diella dovesse produrre risultati verificabili — bandi più competitivi, contenzioso ridotto, tempi più brevi di aggiudicazione, incremento della partecipazione di PMI — l’Albania rafforzerebbe la sua posizione nei capitoli negoziali legati a mercati interni, appalti e Stato di diritto. Se invece l’esperimento si rivelasse un’operazione di marketing politico, il boomerang sarebbe significativo: l’immagine di un “ministro-algoritmo” rischierebbe di cristallizzare i dubbi sulla maturità istituzionale del Paese.
In termini di policy, la chiave è trasformare un’operazione comunicativa in un’infrastruttura di fiducia. Questo passa per atti amministrativi chiari che definiscano ruoli e responsabilità; per contratti tecnologici che garantiscano audit indipendenti, portabilità e reversibilità; per la pubblicazione proattiva di dataset e log in standard aperti; per la separazione netta tra valutazione automatizzata e decisione finale, che deve restare umana, motivata e ricorribile. È anche necessario un investimento nelle capacità del sistema giudiziario e delle autorità di controllo: un algoritmo che segnala anomalie è inutile se le istituzioni non sono in grado di assorbirne gli esiti e sanzionare le distorsioni. La lezione delle migliori esperienze regionali è che l’anticorruzione non è mai un atto singolo ma un equilibrio dinamico tra tecnologie, incentivi, trasparenza e accountability.
In ultima analisi, Diella è un banco di prova per tre domande che vanno oltre i confini albanesi. La prima riguarda il rapporto tra automazione e sovranità democratica: quanto spazio possiamo concedere a sistemi opachi nel cuore del processo decisionale senza svuotarne la legittimità? La seconda chiama in causa l’economia politica del digitale: chi cattura la rendita dell’innovazione nella pubblica amministrazione e con quali condizionalità? La terza è europea: l’allargamento verso i Balcani occidentali sarà credibile solo se le promesse di riforma si tradurranno in risultati misurabili, auditabili e sanzionabili. Se Diella diventerà un apparato di trasparenza verificabile, Tirana avrà davvero inciso sul nodo che più preoccupa partner e investitori; se resterà una narrazione, avremo solo sostituito la discrezionalità di un ministro con l’arbitrio di un algoritmo. La differenza non la fa l’avatar, ma la qualità delle regole e la forza delle istituzioni che le applicano.
*Junior Visiting Fellow Fondazione CSF

 It
It  En
En